Ciao, io sono Eugenio Radin e questa è la newsletter in cui parlo di filosofia e argomentazione. Oggi parliamo di un problema molto serio che riguarda la politica: la fede cieca che nutriamo verso certi leader.
Per inciso, produrre questi contenuti costa tempo e fatica. Se ti piacciono puoi sostenere il progetto iscrivendoti alla newsletter e seguendomi anche sui canali Instagram e TikTok, dove ogni settimana pubblico contenuti di argomentazione e filosofia!
Chi è senza peccato scagli la prima pietra
C’è una vecchia barzelletta che spero non scandalizzi nessun credente.
Gesù scese in piazza ed esclamò: «chi è senza peccato scagli la prima pietra!». Ma subito venne colpito in fronte da un grosso sasso. Massaggiandosi la testa, sospirò: «mamma, ma per una volta non potevi startene a casa?».
Il senso della battuta si gioca tutto sul dogma cattolico dell’Immacolata concezione, secondo cui la madre di Gesù, a differenza di tutti gli altri uomini, sarebbe nata senza peccato.
Ebbene, prima del 1854 questa barzelletta non l’avrebbero capita in molti. Fino ad allora, infatti, quello dell’Immacolata concezione non era un dogma. All’interno della Chiesa si discuteva animatamente tra chi sosteneva che una donna toccata dal peccato originale non avrebbe potuto generare il figlio di Dio, e che di conseguenza Maria doveva essere immacolata, e chi invece riteneva che affermare ciò costituisse un’eresia, perché solo Cristo è senza peccato.
«Quisquilie!», dirà qualcuno. Ma spesso anche dalle quisquilie derivano conseguenze importanti. A risolvere la questione ci pensò il Papa: Pio IX, che l’8 dicembre 1854 proclamò ex cathedra il dogma dell’Immacolata concezione (che, tra parentesi, ancora oggi si festeggia ogni 8 dicembre).
La mossa del Papa costituì uno scandalo ancora più grande di quello della purezza mariana. Nessun Papa, infatti, si era mai sognato di decidere da solo in che cosa fosse doveroso credere.
Certo, da molti secoli il vescovo di Roma era diventato la principale figura della cristianità, ma le decisioni in materia di fede erano sempre passate per i Concili, per le assemblee della curia e per gli altri organi collegiali della Chiesa. In base a quale principio Pio IX si permetteva ora di dettar legge da solo?
Messo alle strette, il Papa agì d’astuzia: convocò in effetti un concilio (il Concilio Vaticano I), ma proprio tramite quel concilio fece approvare, il 18 luglio 1870, la costituzione Pastor Aeternus, che proclamava il principio dell’infallibilità papale. Il Papa, cioè, era sempre nel giusto; ciò che proclamava ex cathedra in materia di fede era senz’altro vero e non poteva essere messo in dubbio, in quanto ispirato direttamente da Dio. Per questa ragione, dunque, non c’era motivo di mettere in dubbio il dogma dell’Immacolata concezione.
Nemmeno nel pieno del Medioevo era mai stato affermato un principio tanto radicale a difesa del papato.
Ironia della sorte, solo due mesi più tardi i bersaglieri italiani riusciranno a penetrare nella Città eterna aprendo una breccia in Porta Pia, permettendo così l’annessione dello Stato della Chiesa al neonato Regno d’Italia. Da allora in poi il Papa è rimarrà senza un regno, ma il principio della sua infallibilità non verrà mai ritrattato e rimane tuttora valido per la Chiesa cattolica.
Dalla religione alla politica
Forse tutto ciò vi sembrerà scandaloso, ingiusto, antidemocratico. Eppure, mentre ci indigniamo nei confronti della Chiesa, il principio dell’infallibilità sembra venir esteso a ogni leader politico. Con un’importante differenza: che mentre la Chiesa non nasconde il fatto d’essere una monarchia assoluta, i Paesi occidentali hanno invece la pretesa di rappresentare un modello di democrazia.
Credo che, al di là degli aspetti superficiali, evidenti a tutti, nella crisi politica internazionale che stiamo vivendo si nasconda un problema profondo, più filosofico, più serio:
Non misuriamo più il valore dei nostri leader sulla base dei nostri princìpi, ma scegliamo i princìpi in cui credere sulla base delle affermazioni dei nostri leader, ritenendoli infallibili.
Le nostre idee politiche sono sempre meno frutto di un ragionamento individuale e sempre più una questione di fede. Siamo sempre più indifferenti al culto divino, ma sempre più vittime del culto della persona nei confronti dei nostri rappresentanti. Scegliamo il nostro leader di riferimento, lo trasformiamo nel nostro personalissimo Messia e gli giuriamo fedeltà anche nella contraddizione, anche quando le sue opinioni sono contrarie ai fatti della realtà.
Chi plaude Trump lo plaude incondizionatamente. Per il popolo MAGA egli non è un funzionario incaricato di sondare soluzioni. Trump è la soluzione: tutto ciò che dice è necessariamente giusto, perché la giustizia coincide con le sue idee politiche.
Allo stesso modo lo zoccolo duro dei meloniani italiani è pronto ad esprimere il proprio sostegno sotto a ogni post social del Presidente del Consiglio, spesso con toni da fanboy: non importa che si tratti del raduno dei conservatori americani o della conferenza stampa con il laburista Starmer. A loro volta i pentastellati non si accorgono che sostenere l’Ucraina ma al contempo negare l’invio di aiuti è una posizione contraddittoria. E via dicendo.
Si forma così una massa acritica, profondamente ignorante e credulona, costretta a cadere a ogni piè sospinto nella fallacia dell’ipse dixit, cioè in quell’errore logico che consiste nell’affermare la verità di una tesi sulla base del fatto che tale tesi è stata sostenuta da un’autorità di riferimento.
Un problema per la democrazia
Platone non era certo un fan della democrazia, ma era un amante della verità e, da buon amante della verità, ha cercato di indicare, in tutta la sua produzione filosofica, il percorso che conduce l’uomo alla vera conoscenza di ciò che è bello, di ciò che è buono, di ciò che è giusto.
Questo percorso parte da una constatazione apparentemente scontata, ma che (forse proprio per questa scontatezza) rischia di venir dimenticata:
Nessun uomo può conoscere in toto la verità. Per usare la terminologia platonica, la conoscenza umana è sempre doxastica: cioè è fatta di doxa, di opinioni. E l’opinione è il contrario della verità, perché, a differenza di quest’ultima, è sempre passibile di errori. Le nostre opinioni sono un qualcosa che può puntare ad avvicinarsi il più possibile alla verità, ma che non coinciderà mai con essa, perché il conoscere umano è viziato dalla nostra limitatezza, dalla nostra emotività, dai giudizi pregressi e da quelli che al giorno d’oggi chiamiamo bias mentali: vizi di ragionamento, errori logici, tendenze psicologiche.
Il bene in sé, il giusto in sé, il vero in sé sono invece concetti intelligibili, cioè hanno a che fare con il regno del puramente razionale. Nel linguaggio platonico, sono conoscenze epistemiche, cioè universali, matematiche, pure. Scopo dell’uomo è quello di esercitare la propria ragione, la propria razionalità, per condurre le proprie opinioni (che rimarranno sempre doxastiche) il più vicino possibile a una conoscenza epistemica e questo scopo si ottiene con il dialogo, cioè con il confronto tra tesi contrapposte.
Come si traduce tutto ciò in termini politici? Se prendiamo gli insegnamenti platonici e proviamo ad applicarli alla nostra partecipazione alla vita pubblica, mi sembra che il corretto modo di ragionare dovrebbe essere il seguente:
Dapprima dovremmo cercare di indagare, tramite la logica e la razionalità, ciò che è giusto, buono, vero, cercando di non cadere nell’emotività e di attenerci ai fatti, ma rimanendo tuttavia aperti al dialogo e all’autocritica. Sulla base di questa indagine razionale, dovremmo secondariamente formarci le nostre idee su ciò che sarebbe più giusto fare nell’una e nell’altra situazione, e solo in un terzo momento dovremmo sondare quale tra le diverse parti politiche si avvicina di più alla nostra visione delle cose e offrigli il nostro sostegno.
Insomma: prima stabilisco quali sono i miei valori, i miei obiettivi, e poi scelgo tra le varie opzioni politiche, quella che più mi rispecchia.
Ma ciò che vediamo succedere, oggi, è l’esatto opposto: prima si sceglie a quale schieramento aderire, prima si sceglie la propria appartenenza, e poi, in base a quell’appartenenza si decide cosa è vero e cosa è falso, decretando l’infallibilità del proprio leader.
Alla domanda: «In cosa credi?» non rispondiamo più: «Alla libertà»; «All’uguaglianza»; «Alla famiglia»… Risponderemo invece: «Credo in ciò che dice il mio leader», al quale finiamo per sacrificare la nostra capacità di giudizio.
È questo il problema più profondo per la democrazia. Perché se la giustizia e la verità finiscono per coincidere con le opinioni di un leader infallibile, il confronto con altre parti politiche verrà visto solo con un impedimento al raggiungimento della verità e non, invece, come un cammino dialogico volto a superare la limitatezza di singole doxa.
Al momento, forse, la democrazia sopravvive per inerzia - perché molti di noi sono cresciuti nella convinzione che essa fosse un bene. Ma quanto a lungo potrà sopravvivere se verranno meno le basi filosofiche che ne costituiscono il fondamento?
Diventare maggiorenni
Se vogliamo impedire il crollo della democrazia, dobbiamo allora lavorare sulle idee. Recuperare la grande lezione concettuale che all’Occidente venne insegnata dai philosophes dell’illuminismo e che contribuì alla fine dell’ancien règime e al principio di un’epoca nuova in cui la libertà si sostituiva all’obbedienza; l’individuo si sostituiva all’autorità; il dispotismo lasciava spazio ai primi esperimenti di democrazia.
Kant condensava in un motto l’intera essenza dell’illuminismo: «Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!». I principali nemici di quella portentosa rivoluzione culturale, per lui, non erano i despoti delle grandi monarchie europee, ma la nostra stessa pigrizia e la viltà, che ci rendono incapaci di servirci della Ragione per sviluppare da noi le nostre idee sul mondo e che, anche quando da tempo siamo maggiorenni da un punto di vista anagrafico, ci riducono alla condizione di eterni minorenni da un punto di vista intellettuale.
È così comodo essere minorenni! - scrive Kant - Se ho un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me […], ecc., non ho certo bisogno di sforzarmi da me.
L’illuminismo kantiano ci invita a liberarci da quei tutori politici che pretendono di far valere le loro opinioni come fossero verità assolute, e ci insegna che l’unico modo per farlo è fare lo sforzo di ragionare da sé. Il che, si badi, non significa pensare ciò che si vuole, né ritenere che “uno vale uno”. Significa assumersi la fatica di comprendere, di studiare, di esercitare la logica, di confrontarsi con chi non la pensa come noi. Significa rivendicare quello spazio di dialogo che si frappone, per dirla con Platone, tra la nostra opinione e la verità intelligibile.
Un consiglio per concludere
Scommetto che, leggendo questa newsletter, stavi pensando ai tuoi avversari politici. Se sei di sinistra avrai pensato: «È vero! I trumpiani, i meloniani, sono proprio così!»; se sei di destra avrai pensato che «È vero! La sinistra crede acriticamente alle bugie dei suoi leader». Ma è su te stesso che devi fare il grosso del lavoro.
Kant non ti invita a mettere in dubbio le convinzioni degli altri, ma a esercitare la razionalità in primis su te stesso!
Voglio proporti un semplice esercizio per iniziare a farlo. Pensa al tuo leader politico di riferimento, quello che voteresti o che hai votato alle ultime elezioni: Meloni, Schlein, Conte, Salvini... chi preferisci. Ora pensa ad almeno tre posizioni politiche da lui espresse, con le quali sei in disaccordo. Possono essere posizioni riguardanti l’economia, il lavoro, l’ambiente, l’istruzione… ciò che vuoi. Non valgono però risposte del tipo: «È stato troppo poco duro con gli avversari» o «Avrebbe dovuto essere più irremovibile su questo punto». Qui infatti si critica l’atteggiamento, ma indirettamente si sta dicendo che si è d’accordo con le convinzioni di fondo. Provate invece a trovare tre posizioni su cui la vostra visione del mondo differisce sensibilmente.
Se non ci riuscite, se vi sembra di essere d’accordo al 100% con i vostri leader, dovrebbe accendersi in voi una spia rossa: forse siete voi stessi vittime di questa spirale ideologica.
Grazie per avermi letto fin qui, se vuoi puoi farmi sapere che ne pensi rispondendo a questa mail: leggerò con piacere il tuo commento. Ricordati anche, se già non l’hai fatto, di iscriverti alla newsletter per non perderti le prossime uscite!
Riguardo all’Illuminismo e allo spirito di pensiero che dovremmo sforzarci di recuperare, ti consiglio questo saggio di Tzvetan Todorov, Lo spirito dell’illuminismo, che ho letto un paio d’anni fa.
A tratti ho avuto l’impressione che Todorov rischiasse di usare un doppio standard per giudicare le colpe dell’Occidente rispetto ai problemi derivanti da altre culture, ma al di là di questo sa dare una buona infarinatura di base su quelle che, al di là dell’apporto dei singoli pensatori, sono le idee che stanno alla base della rivoluzione illuminista.
Se vuoi, puoi sostenere il mio progetto acquistando il libro dalla mia pagina affiliata Amazon: per te il prezzo rimarrà lo stesso, ma una percentuale mi verrà riconosciuta dalla piattaforma. Buona lettura e Sapere Aude!







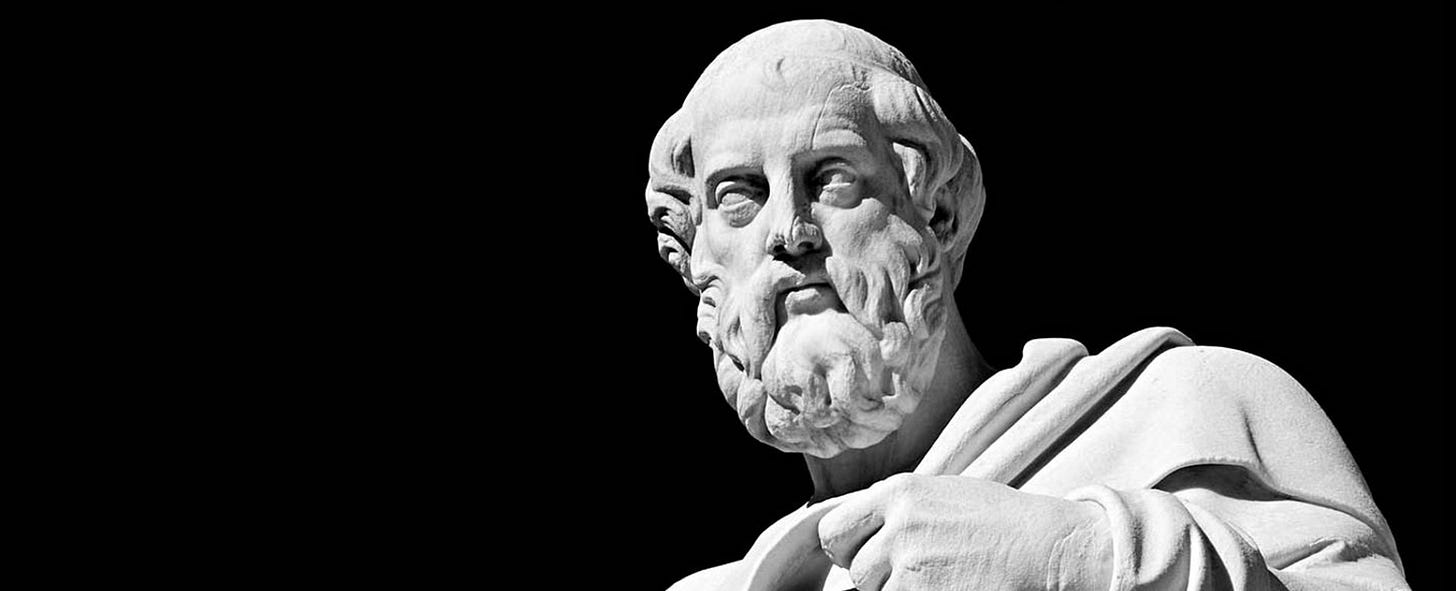

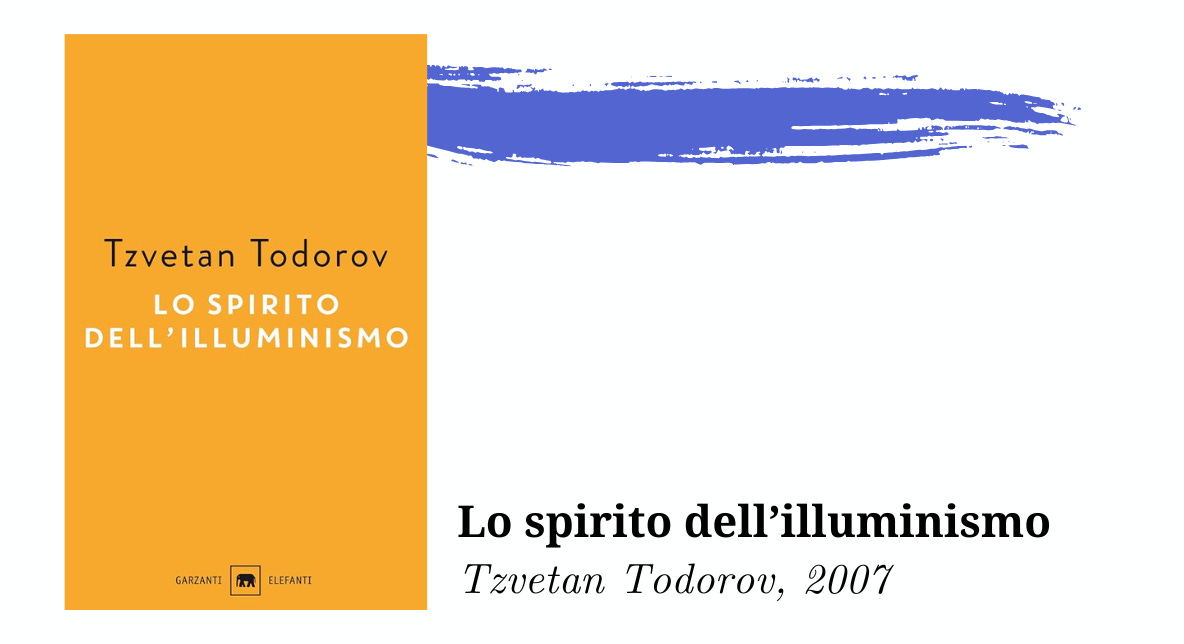
«Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!». Potente, grazie
Ciao Eugenio,
grazie per questa tua riflessione, sempre acuta e ben argomentata. Seguo regolarmente le tue “pillole” su Instagram e trovo che il tuo approccio critico sia un ottimo stimolo per mettere in discussione certezze che spesso diamo per scontate.
Sono pressoché d’accordo su tutto, anche se lavorare su se stessi in questo senso non è affatto semplice: il nostro amor proprio e la tendenza a seguire schemi consolidati rendono il processo tutt’altro che lineare.
A volte, però, mi chiedo: siamo davvero convinti di vivere in una democrazia? L’Europa appare sempre più vincolata alle logiche di potenza degli USA, mentre l'Italia sembra perdere ogni confronto strategico, come dimostrato dal caso libico. I cittadini, nel frattempo, partecipano sempre meno alla vita politica, i media sono schierati, e l’idea che il nostro modello sia universalmente invidiato sembra più una narrazione autocelebrativa che una realtà condivisa.
Se poi guardiamo alla storia, le democrazie moderne come le intendiamo oggi nemmeno esistevano ai tempi di Kant, Schopenhauer o Platone. Eppure, proprio in quei contesti, tra regimi autoritari, imperi e città-stato oligarchiche, si sono formati i grandi pensatori che hanno gettato le basi del pensiero critico e della filosofia politica. Forse è proprio nei momenti di massimo contrasto e apparente decadenza che nascono le idee più illuminanti.
Nel caos mediatico attuale, viene spontaneo domandarsi: ha ancora senso arrovellarsi su questi temi, o stiamo solo alimentando un dibattito sterile senza effetti concreti? Forse, nonostante tutto, vale la pena continuare a cercare delle risposte.
Grazie ancora per il tuo lavoro, alla prossima!